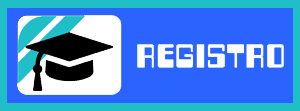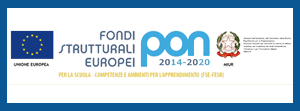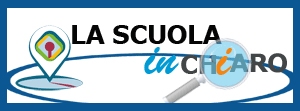Il Tricolore italiano nasce nel 1796, come bandiera militare delle repubbliche Cispadana e Cisalpina, per distinguere il contingente italiano all’interno dell’esercito di Napoleone Bonaparte. Nel 1848 viene adottato dai Savoia nel Regno di Sardegna; nel 1861 dal neonato Regno d’Italia, sino a diventare bandiera nazionale nel 1946. Il tricolore viene raffigurato in svariate opere pittoriche, rappresentando un percorso di lotte e ideali, lungo due secoli, passando dalle allusioni più nascoste della pittura ufficiale del primo ‘800, alle esplicite rivendicazioni risorgimentali, fino alle moderne allegorie del ‘900. Se l’arte è un modo per conoscere e rappresentare la realtà, qui diventa utile per comprendere il complesso intreccio di implicazioni (politiche, simboliche, sociali e culturali) che accompagnano il cammino verso l’Italia unita e verso il suo consolidarsi come uno degli Stati dell’Europa moderna. I dipinti selezionati per questo contesto, regalano testimonianze della realtà storica, facendo luce su avvenimenti fondamentali.

Francesco Saverio Altamura, La prima Bandiera Italiana portata in Firenze, 1859. Museo del Risorgimento, Torino
Opera molto significativa, raffigura un giovane uomo che si reca sul colle di San Miniato, tenendo sulla spalla il tricolore. A conferire un carattere intimo e personale al momento storico, avvenuto il 27 aprile del 1859, è sicuramente la luce con un effetto naturale e morbido.
.

Gioacchino Toma, Piccoli patrioti, 1862. Collezione privata
Pittore e patriota che combatté per Garibaldi, divenne noto per il suo talento artistico che lo portò a rappresentare molte scene storiche, dallo stile verista e dal sapore malinconico e sentimentale, frutto della sua infanzia infelice, causata dalla prematura morte di entrambi i genitori e il conseguente abbandono dei parenti. L’arte diventa per lui una forma di rivalsa e di impegno civile per costruirsi una vita rispettabile. In questo spazio domestico, entro il quale si muovono in autonomia, tre bimbi intenti a giocare a fare i soldati, ogni elemento è descritto con precisione e trasporto emotivo. Il messaggio è l’importanza di rendere consapevoli, già in tenera età, quelli che saranno i futuri cittadini. Svelare loro, la verità della storia e le difficoltà che si celano dietro la ricostruzione di una nazione, dilaniata da lotte, soprusi e mancanze.

Gerolamo Induno, Roma (La bandiera nazionale), 1863. Quadreria dell’800, Milano
All’interno di un’abitazione contadina, tre donne sono impegnate (con fare furtivo), nel rammendo di una bandiera italiana, di cui scorgiamo la presenza sul tavolo da lavoro. I sentimenti patriottici dell’artista si riflettono in questa realizzazione realistica, piena di sentimento e di attaccamento della popolazione verso la Patria appena nata. Una Patria che necessita di cure, protezione e amore.

Luigi Riva, Plebiscito Romano, 1874. Museo del Risorgimento, Milano
Il dipinto a olio testimonia un evento importante: il Plebiscito romano, che si svolse il 2 ottobre 1870, per decidere l’annessione al Regno d’Italia, dei territori di Roma e delle province di Civitavecchia, Frosinone, Velletri e Viterbo. La domanda riportata sulle schede di votazione fu: “Desideriamo essere uniti al Regno d’Italia, sotto la monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele II e dei suoi successori?”. Complessivamente, su 167.548 elettori, 135.291 si recarono alle urne. La vittoria del “SÌ” fu schiacciante: 133.681 voti favorevoli, 1507 contrari e un centinaio i voti nulli. Con questo risultato, Roma e i suoi territori, dal 9 ottobre 1870, furono annessi ufficialmente al Regno, con regio decreto (n. 5903). Venne dunque portato a termine il progetto di nazione unitaria, auspicato dai quattro “Padri della Patria”, ispirato da Mazzini, appoggiato militarmente da Garibaldi e politicamente promosso da Cavour sotto l’egida del Re Vittorio Emanuele II.
L’autore del quadro, Luigi Riva, non ritrae una fanciulla votante: ricordiamoci che all’epoca, solo gli uomini, alfabetizzati e benestanti, potevano votare, scelti dunque per stato e per censo. (Un dato che può farci riflettere sull’uso del termine “plebiscitario”). La prima votazione aperta alle donne in Italia, avverrà solo nel 1946, in occasione del referendum del 2 giugno, per scegliere tra monarchia o repubblica. Il pittore dipinge un’allegoria: la ragazza è Roma, che vestita con il costume folkloristico, si avvicina all’urna stringendo nella mano del cuore, un biglietto con scritto Sì. Il suo corpo è proteso in avanti, verso una stele che fa da basamento al mezzobusto del Re. Il suo profilo è appoggiato allo stemma imbandierato e sembra quasi voler sussurrare una frase, come un giuramento. Forse, qualcosa di simile a questo: “Non c’è nulla d’immutabile, la trasformazione è la regola dell’eterno. La mia storia è la testimonianza di un incedere perpetuo, di un moto regolato da ideale e desideri, che portano il sigillo della libertà e del progresso. La mia Storia è quella delle braccia che mi hanno plasmata, la Storia degli uomini che mi hanno attraversata e ammirata. E’ la storia di lunghe contese che mi hanno reso terreno di battaglia e simbolo di conquiste. La mia Storia è la Storia di quelle forze che mi hanno scossa e di quelle che ho imparato a domare. E’ la Storia della polvere che si è sollevata dalle rovine annebbiando il mio volto e quella della luce negli occhi, di chi ha sognato il giorno della mia rinascita. Nelle mie arterie scorrono la memoria della perdita e del sacrificio, il fuoco della speranza che accompagna i nuovi inizi e quello della passione di chi mi ha immaginato come il glorioso emblema del Nuovo Regno. Sulla mia pelle l’incertezza del cambiamento ha assunto le tante forme dell’opportunità, fino a rendermi quella che sono. Chi sono? Io sono Roma”. (Citazione su Roma, tratta dalla Mostra “Nascita di una Capitale, 1870-1915”, Museo di Roma, Palazzo Braschi. Maggio-settembre 2021).

Gerolamo Induno, La partenza dei coscritti dell’anno 1866, 1878. Museo del Risorgimento, Milano
L’opera era stata eseguita nel 1878, su commissione di Vittorio Emanuele II ed inviata all’Esposizione Universale di Parigi dello stesso anno, con il titolo Italie 1866. Nel 1881 Induno ne dipinse una copia, di proporzioni minori, (Museo Borgogna, Vercelli), per l’Esposizione Nazionale di Milano, dove fu acquistata dal collezionista Antonio Borgogna. La scena si svolge in un villaggio prealpino, della Brianza o della Valtellina, di fronte alla scalinata della chiesa e alla scuola comunale. Un gruppo di coscritti, salutando le proprie famiglie, si accinge a partire per la terza guerra di indipendenza del 1866, sotto lo sguardo del sindaco, del parroco e del maestro. Al centro della scena, animata da una teatrale coralità, campeggia la bandiera italiana, simbolo dell’unità nazionale. L’autore, insieme al fratello Domenico, fu un pittore-soldato, partecipe attivamente tra le file dei garibaldini, che più volte affrontò nelle sue opere, tematiche storiche legate ai moti risorgimentali. In questa tela l’osservazione del reale, del quotidiano popolare, si associa ad uno sguardo amaro e disincantato verso gli ideali del Risorgimento, trasponendo il soggetto attraverso una personale, malinconica poetica.

Henry Holiday, Dante e Beatrice, 1883. Walker Art Gallery, Liverpool
La tela raffigura il famoso incontro di Dante Alighieri e Beatrice Portinari, sul Ponte Santa Trinità di Firenze, ad opera del preraffaellita inglese Henry Holiday. Beatrice indossa una tunica bianca, mentre al suo fianco, l’amica Vanna, in rosso, cerca Dante con lo sguardo. Poco distante, da loro, si appresta una domestica, vestita di blu. I colori degli abiti, non sono casuali, poiché rimandano alle tinte delle bandiere nazionali (quella dell’autore e quella dei protagonisti). Il bianco di Beatrice, insieme al rosso e al blu delle sue accompagnatrici, rappresenta infatti, la bandiera inglese, simboleggiando la purezza delle virtù britanniche, mentre il verde della veste di Dante, posto sulla destra, letto insieme alle due figure femminili principali, contribuisce a creare la bandiera del neonato Regno d’Italia (1861). L’opera simboleggia, dunque, l’incontro tra la cultura inglese e quella italiana, incarnando la forte influenza e la grande importanza che la nostra arte possedeva, in quel periodo, su quella d’oltremanica.

Carlo Stragliati, Episodio delle Cinque Giornate di Milano (1848), 1890 ca. Museo del Risorgimento, Milano
Immagine suggestiva ed emblematica, rappresenta la più importante rivolta cittadina del Risorgimento, significativo preludio alla Prima Guerra d’Indipendenza. Due giovani donne, affacciate ad una finestra, sventolano il Tricolore, simbolo dei valori unitari. Il loro sguardo fiero, rivolto al futuro, esprime le speranze delle nuove generazioni, di quel popolo minuto che sacrificò tutto per avere una patria unita. All’interno della stanza, una vecchietta sorride al nuovo corso della storia, tenendo tra le mani un lembo di stoffa. La gente nella piazza è in festa e dagli altri balconi si vedono sventolare le bandiere, trasmettendo la gioia diffusa tra i milanesi. La donna, relegata a ruolo marginale entro le mura di casa, appare ora in una nuova veste, al fianco degli uomini, esternando propri i sentimenti di unità e di partecipazione politica. Alle donne venne affidato in quei giorni il compito di cucire a mano, in clandestinità, le bandiere tricolore, nascondendole alle autorità: ai piedi dell’anziana donna, infatti, appare un piccolo cesto con gli strumenti da cucito, le forbici, il filo.
Giacomo Balla, Dimostrazione interventista, 1915 ca. Museo della Grande Guerra, Gorizia
L’opera è stata una recente scoperta, perché per oltre un secolo, è rimasta nascosta da uno strato di pittura nera, sul retro di un altro quadro (Verginità, 1925), dell’autore. Eseguita in un clima di estrema tensione politica e culturale, in cui parte degli intellettuali italiani erano schierati come lui, a favore dell’intervento dell’Italia in guerra, esprime tutta l’energia e il dinamismo conflittuale di quel frangente. Nella composizione, pienamente astratta (sono assenti riferimenti alle forme naturali), linee rette e curve si intersecano, creando triangoli e superfici dalle tinte squillanti, a rappresentare le forze innovative interventiste (il tricolore) e quelle di resistenza neutralistica. Una tramatura nera opprime la nazione, mentre il nodo sabaudo posto al centro, ne sancisce l’unità nazionale.
Cafiero Filippelli, Il Tricolore, 1920
Una scena buia, illuminata da una lampada centrale che segna la presenza di una donna che, con il capo chino, rammenda un tricolore. La luce investe la bandiera, rendendola protagonista del dipinto, erigendola concettualmente, a faro di luce, per un intero popolo. Una rappresentazione in uno scenario casalingo, capace di testimoniare l’attaccamento del popolo ad un simbolo, tanto importante. L’esecuzione di questa opera è datata durante la guerra Italo-Turca per la conquista della Libia.
In occasione della Giornata nazionale del Tricolore ’23, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha citato questo quadro come “un’immagine straordinaria”, metafora dell’impegno quotidiano per ricucire ciò che è strappato, riannodando i fili del nostro stare insieme, per riscoprirsi comunità: una strada da seguire, per liberare le energie migliori della nazione e rendere l’Italia ancor più protagonista in Europa e nel mondo.
Michelangelo Pistoletto, Stracci d’Italia, 2007
Allestita per l’occasione del 150° dell’Unità d’Italia nella torre cilindrica della città di Salerno, da dove Garibaldi issò il primo tricolore dell’Italia Unita nel 1860, è un’opera formata da lembi di stoffe fissate ad un supporto, atte a creare un tricolore in 3D, posto in verticale. Gli stracci, per Pistoletto, fondatore dell’Arte Povera, hanno un ruolo fondamentale. (Ricordiamo, ad esempio, la sua Venere degli stracci del 1967, nota opera di riferimento della storia dell’arte contemporanea). Lo straccio come materiale semplice, di scarto… povero, capace di acquisire dignità e valore, divenendo mezzo espressivo, artistico. Qui, si erge a vessillo nazionale, rappresentando un corpus dato da pezzi diversi che uniti, pur sovrapposti, disordinati, mutevoli nella loro posizione, poiché fissati solo su un lato corto, sanno comporre una forma di facile e chiara lettura. La matrice concettuale del gesto artistico dell’autore, ridefinisce l’uso dei materiali di produzione industriale e degli scarti urbani, in una trasformazione che conferisce loro, una nuova dignità e una nuova destinazione, nell’ottica di un’arte capace di essere impegno sociale, per una nuova e più consapevole società contemporanea.